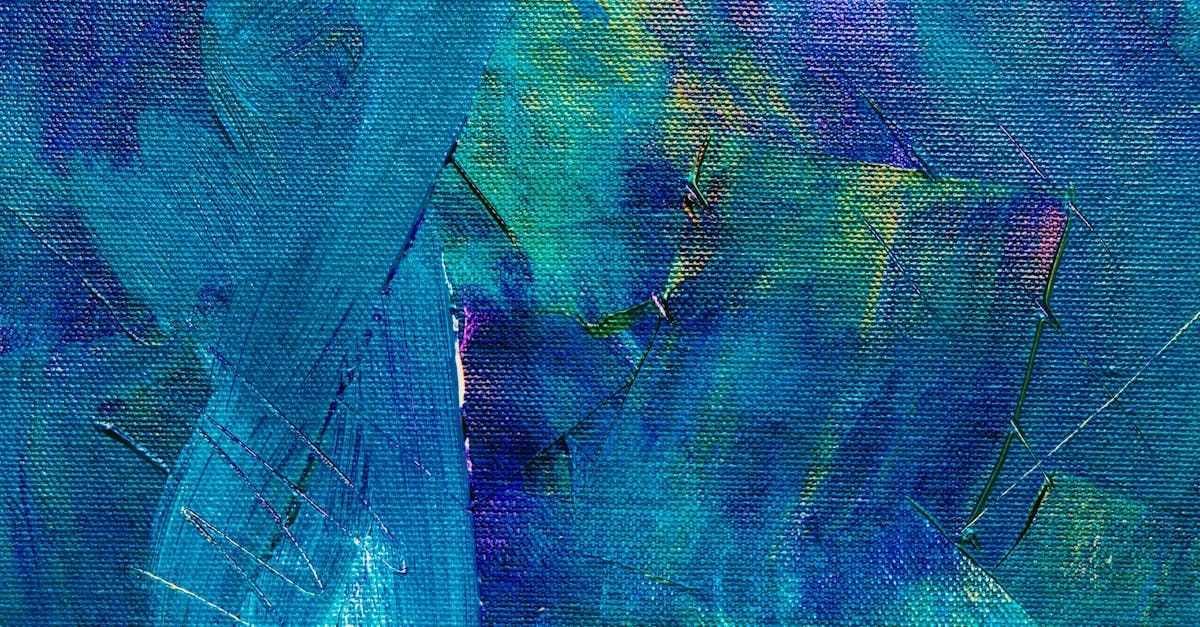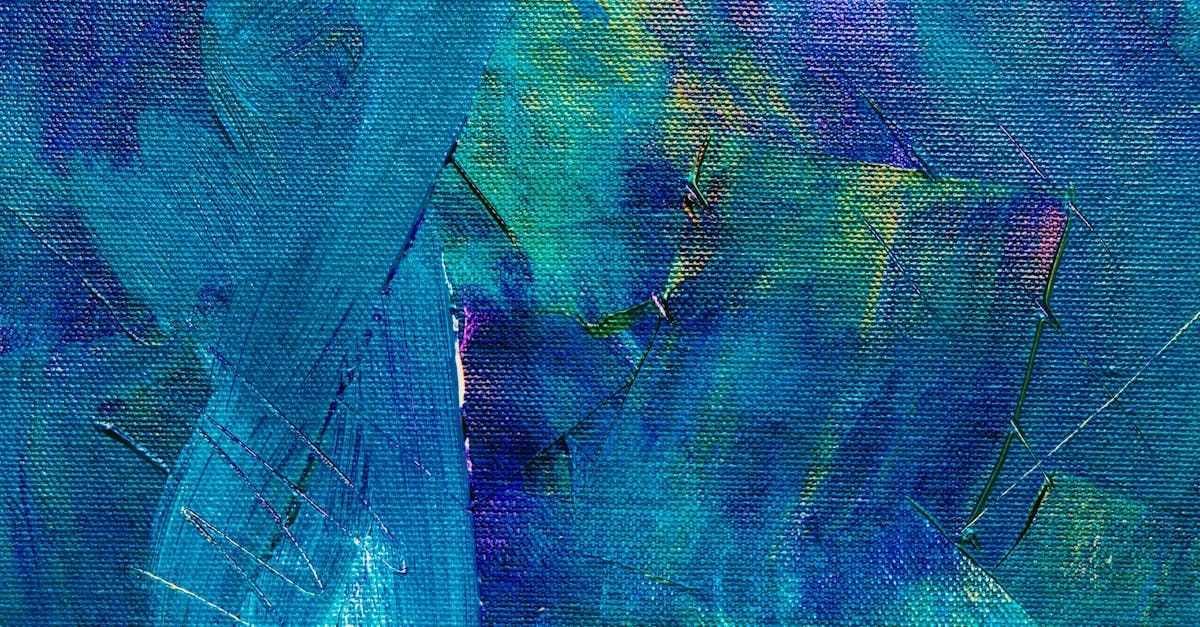


1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Tivoli da A.A. nei confronti di B.B. e C.C., con la quale l'attrice chiese che fosse dichiarata l'inesistenza del livello catastalmente iscritto su un terreno di sua proprietà di 2.780 mq, iscritto al foglio (Omissis) del catasto del comune di (Omissis); in via subordinata, la medesima chiese che il livello fosse dichiarato estinto per prescrizione e, in ulteriore subordine, che nessuna prestazione pecuniaria fosse esigibile da parte dei D.D..
A.A., cui il terreno era pervenuto in forza di successione mortis causa, espose che esso era stato acquistato dai suoi danti causa E.E. e a F.F. da H.H., con atto del (Omissis); dalla visura catastale risultava che detto terreno, gravato da un "livello" a favore di I.I., con usufrutto parziale a favore di L.L., rientrava tra quelli per i quali il dominio diretto era stato ceduto, con atto rogato dal notaio M.M. in data (Omissis) a N.N., dante causa di B.B.. L'attrice evidenziò come l'unico atto dal quale poteva desumersi l'origine del "livello" era l'atto notarile del (Omissis), con cui il Principe O.O. aveva qualificato i concessionari non come enfiteuti, ma come coloni perpetui ma da tale atto non risultava che il terreno rientrasse tra quelli gravati da livello.
L'attrice invocò l'estinzione del livello, anche ai sensi della L. n. 3 del 1974, art. 2 che riguardava in via generale le prestazioni fondiarie perpetue.
2. Il Tribunale di Tivoli dichiarò la carenza di legittimazione passiva di C.C., accolse la domanda nei confronti di B.B. e dichiarò insussistente il livello iscritto sul terreno.
Secondo il Tribunale, non vi era la prova che il terreno dell'attrice rientrasse tra quelli gravati da livello e, in ogni caso, anche ammettendo l'esistenza del livello, esso si era estinto per commutazione di prestazioni fondiarie in natura, ai sensi della L. 4727 del 1887.
3. Sul gravame proposto dal convenuto, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda attorea.
La Corte rilevò che era stata la stessa attrice ad individuare nell'atto del (Omissis) quello con cui I.I. aveva ceduto a N.N., dante causa di B.B., il dominio diretto sul terreno oggetto di causa. Era stata la stessa attrice ad affermare che, con atto del (Omissis), i propri danti causa avevano acquistato il terreno gravato da livello. Secondo i giudici di appello, A.A. avrebbe dovuto dimostrare di aver acquistato un terreno non gravato da livello e, a tal fine, non era rilevante l'indagine sull'atto per notar P.P. del (Omissis), costitutivo del livello.
Quanto alle commutazioni intervenute nel (Omissis), secondo la Corte di merito, mancava la prova che la conversione del canone in denaro avesse estinto il diritto reale sempre perchè dai citati atti notarili del (Omissis) e del (Omissis), il livello risultava ancora esistente. Era, infine, inapplicabile, ai fini dell'estinzione del livello, la disciplina di cui alla L. n. 3 del 1974 perchè riferibile ai terreni situati in (Omissis).
4. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma ricorre per cassazione A.A. sulla base di sette motivi.
B.B. è rimasto intimato.
Il Pubblico Ministero nella persona della Dott.ssa Rosa Maria Dell'Erba, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c.., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; secondo la ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, in materia di azione di accertamento negativo l'onere della prova incomberebbe sul convenuto e non su parte attrice.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, per avere la Corte di merito, con motivazione apparente, affermato che era onere della A.A. provare che il proprio acquisto avesse un oggetto più ampio rispetto a quanto riportato nel titolo.
2.1. I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi.
La Corte d'appello, con motivazione non apparente, ha accertato che il terreno pervenuto iure successionis a A.A. era gravato da livello sulla base dell'atto del (Omissis), con il quale I.I. aveva trasferito a N.N. il dominio diretto. A fondamento del proprio convincimento, la Corte d'appello ha, altresì, richiamato l'atto di acquisto dei danti causa della A.A. del (Omissis), cui risultava che il fondo era gravato da livello in favore dei I.I. e del Comune di (Omissis), sulla base dell'iscrizione catastale.
Ne consegue che, indipendentemente dalla correttezza della decisione, il giudice di appello non ha fatto applicazione del principio dell'onere della prova, ma ha fondato la propria decisione sugli elementi probatori acquisiti al processo (Cass., Sez. II, 12/03/1980, n. 1666).
Come affermato da questa Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., Sez. III, 29.5.2018, n. 13395; Cass., Sez. III, 23.10.2018, n. 26769; Cass., Sez. III, 17.6.2013, n. 15107).
3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 948, 957, 960, 967, 969, 2697, 2721, 2729, 2730, 2909 c.c. e artt. 116 e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte d'appello non avrebbe rilevato che si era formato un giudicato interno sulla mancata prova della sussistenza del rapporto di enfiteusi, in quanto con l'atto d'appello il B.B. si sarebbe limitato a chiedere una consulenza tecnica per accertare che il fondo fosse gravato da enfiteusi. La ricorrente richiama un precedente di questa Corte (Cass. 12.12.1949), secondo cui chi afferma che un fondo forma oggetto di enfiteusi deve esibire il titolo costitutivo e la prova di essere successore a titolo universale o particolare del concedente oppure produrre l'atto di ricognizione che intercorre tra direttario e concedente. Nel caso di specie, tale prova non potrebbe ricavarsi dall'atto per notar M.M. in data (Omissis), con il quale era stato ceduto il dominio diretto a N.N., dante causa di B.B., in quanto a tale atto sarebbero estranei gli enfiteuti, nè il titolo avrebbe valore ricognitivo in quanto privo degli elementi del negozio riconosciuto. La prova dell'atto costitutivo dell'enfiteusi non potrebbe ricavarsi dai dati catastali attesa la loro idoneità a provare la sussistenza dei diritti reali. Parimenti, l'esistenza del livello non potrebbe essere provata per presunzioni, essendo necessario valutare il contenuto dell'atto costitutivo, ovvero del rogito P.P. del (Omissis), nè il riferimento all'utile dominio contenuto nell'atto del (Omissis) avrebbe contenuto confessorio perchè la confessione ha ad oggetto fatti e non situazioni giuridiche.
4. Con il quarto motivo di ricorso, deducendo la violazione dell'art. 132 c.p.c., la ricorrente contesta l'apoditticità e la mera apparenza della motivazione sul punto della supposta efficacia probatoria dei rogiti del (Omissis) e del (Omissis) in merito alla sussistenza del rapporto enfiteutico.
5. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) con riferimento al rogito P.P. del (Omissis), da cui si evincerebbe che era stato costituito non un rapporto di enfiteusi, ma di colonia perpetua.
5.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono fondati nei limiti di cui in motivazione.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il "livello" si identifica in un diritto reale di godimento assimilabile all'enfiteusi (cfr. Cass. 1366/1961, Cass. 1682/1963, Cass. 64/1997, Cass. 23752/2011, Cass. 9135/2012, Cass. 3689/2018). Il termine "livello", derivante da libellus - la scrittura in doppio originale (duo libelli pari tenore conscripti) con cui veniva stipulato il contratto costitutivo del diritto e nel quale venivano documentati gli obblighi delle parti - designa un contratto conosciuto già nel tardo diritto romano e molto diffuso nel medioevo e fino alle soglie dell'età contemporanea, avente ad oggetto il possesso e lo sfruttamento, generalmente con clausole di miglioria, di fondi rustici, o anche urbani.
Sulla natura e disciplina dell'istituto in esame, la Corte Costituzionale, con sentenza del 9.7.1959, n. 46, ha affermato che l'istituto del livello è stato dal legislatore considerato nella sua autonomia e disciplinato con criteri autonomi, che in parte coincidono ed in parte contrastano con la disciplina giuridica dell'enfiteusi e degli istituti similari. La Corte di legittimità ha, però, affermato che i livelli erano soggetti alla disciplina del contratto enfiteutico vero e proprio perchè il livello non corrisponde nel diritto positivo vigente - e del resto non corrispondeva neppure nel passato - ad un istituto giuridico che presentasse una sua autonomia giuridica rispetto all'enfiteusi.
Con il contratto di livello, il concedente si obbligava a mantenere il livellario nella concessione senza, in tanti casi, pretendere un corrispettivo (detto censo, spesso in natura o in denaro) o pretendendo un corrispettivo simbolico (censo livellare). Il livellario, titolare di un diritto reale di godimento, era tenuto a curare e migliorare le terre. Il diritto del livellario era estremamente ampio, poichè poteva compiere ogni attività sul terreno, anche alienarlo o assoggettarlo a servitù, fermo restando il diritto di prelazione del concedente.
Secondo autorevole dottrina, la disciplina dell'enfiteusi, nell'ambito degli istituti di antica tradizione contemplati nel Libro sulla proprietà, rispecchia l'antica distinzione tra un dominio utile del soggetto - l'enfiteuta, al quale sono attribuite nella sostanza facoltà assai simili a quelle di un dominus - ed un dominio eminente e diretto in capo al concedente, al quale sembra far capo la sola formale qualità di proprietario, poichè il corrispondente diritto è quasi integralmente svuotato di contenuto.
Nella successiva evoluzione storica, fino ai nostri giorni, i nomi "livello" ed "enfiteusi" vennero promiscuamente adoperati nell'uso comune, per modo che i due istituti, pur se originariamente distinti finirono in prosieguo, già prima delle codificazioni moderne, per confondersi ed unificarsi, con la conseguente estensione della generale disciplina sulla enfiteusi anche ai livelli.
La figura del livellario e quella dell'enfiteuta appaiono infatti considerate unitariamente, ad esempio, nel Regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con il R.D. n. 1539 del 1933, con riguardo le modalità di intestazione dei beni (art. 55) e nel Regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con il R.D. n. 2153 del 1938, con riguardo alle modalità di redazione della nota di voltura (art. 29).
Si realizzò, pertanto, nel corso dei secoli una totale fusione tra i due istituti a vantaggio dell'enfiteusi, con la conseguente estensione, in maniera diretta ed analogica, ai livelli della disciplina e della normativa prevista per l'enfiteusi dal codice civile e dalle varie leggi speciali che si sono succedute nel tempo.
Quanto all'estinzione del diritto, l'esame dell'atto costitutivo è essenziale per accertare se il contratto prevedesse un termine o fosse perpetuo, integrando una colonia perpetua (Cass., Sez. III, 15.6.1985, n. 3601). Sempre l'atto costitutivo consente di verificare l'effettiva natura del rapporto intercorso tra le parti, avendo questa Corte affermato che non possa considerarsi costitutivo di enfiteusi il contratto che, oltre a non prevedere l'obbligo di miglioramenti, rechi una destinazione del fondo oggettivamente incompatibile con ogni successiva miglioria (Cass. 10646/1994).
A tali principi non si è uniformata la Corte d'appello.
L'indagine relativa all'esistenza del livello è stata condotta sulla base del titolo di proprietà di N.N., dante causa di B.B., al quale I.I. aveva ceduto il dominio diretto sul terreno, nonchè sulla base dell'atto di acquisto del (Omissis) del dante causa di A.A., B.B., da cui risultava che il fondo era gravato da livello.
I giudici di appello hanno ritenuto superfluo l'esame del titolo originario costitutivo del livello, l'atto per notar P.P. del (Omissis), che era, invece, necessario, in primo luogo, per verificare se il fondo oggetto di causa rientrasse tra quelli gravati da livello, a fronte della contestazione dell'attrice in ordine all'inclusione del fondo tra quelli indicati nell'atto costitutivo. L'atto di provenienza consentiva, inoltre, di individuare la natura giuridica del livello, le obbligazioni poste a carico del concedente e del livellario e la durata del livello.
Erroneamente la Corte d'appello ha limitato l'indagine ai titoli di proprietà delle parti e ha dato rilievo all'iscrizione catastale del livello sul fondo della proprietà dell'attrice, nonostante la giurisprudenza di questa Suprema Corte abbia escluso valore probatorio alle risultanze del catasto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può, in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti, essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali (Cass., 24.8.1991, n. 9096). Ne discende che, in materia di rivendica o di accertamento della proprietà e di altri diritti reali, la prova deve avvenire sulla base dei titoli (Cass., n. 3398/1984; Cass., n. 3398/1984; Cass., n. 4716/1980).
6. I motivi in esame (terzo, quarto e sesto) vanno, pertanto accolti, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:
"Il regime giuridico del livello va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento. L'esistenza del livello deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali".
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo, il quarto e il sesto motivo di ricorso per quanto di ragione; dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Cassazione Civile, sentenza 6 novembre 2023, n. 30823.